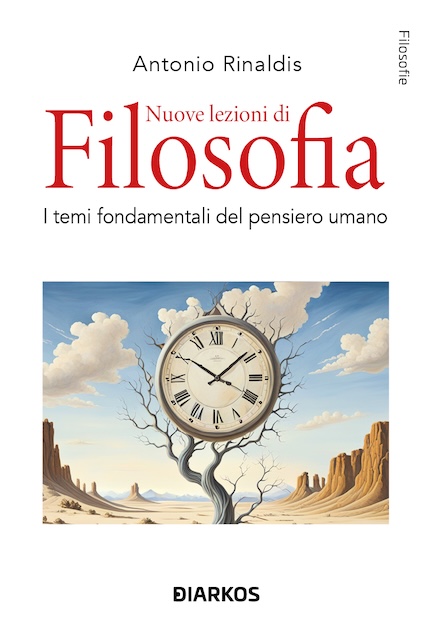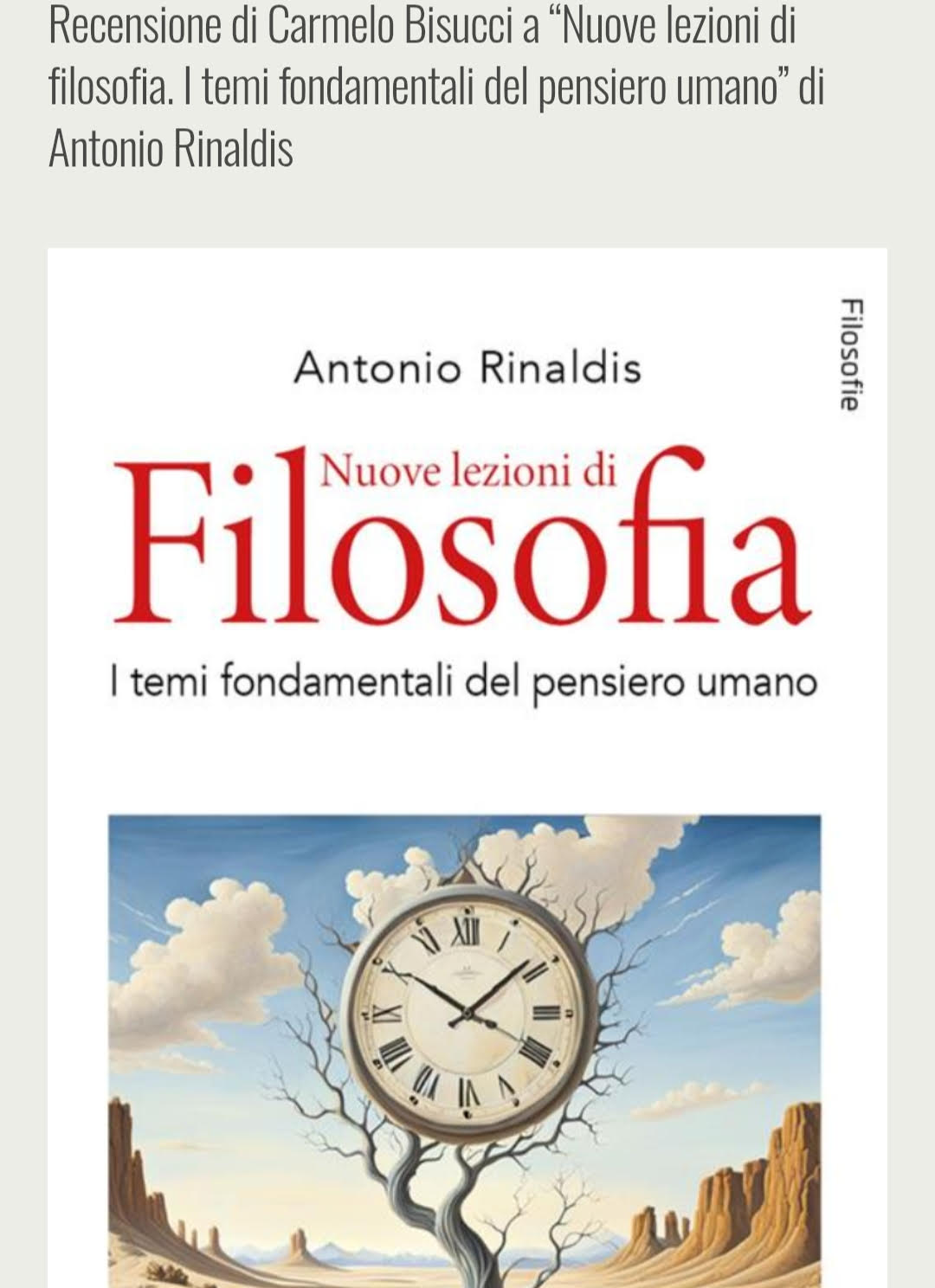
Recensione di Carmelo Bisucci a “Nuove lezioni di filosofia. I temi fondamentali del pensiero umano” di Antonio Rinaldis - Le Voci di Sophia
22 Luglio 2025
Amore, bellezza, morte e verità: questi i temi analizzati concettualmente prima che cronologicamente da questo testo, che consente di chiedersi se ci siano approdi definitivi, porti sicuri che possono costituire una base e un riferimento per l’uomo contemporaneo.
Il libro Nuove lezioni di filosofia. I temi fondamentali del pensiero umano di Antonio Rinaldis, edito da DIARKOS, fa seguire a queste quattro macrocategorie eventi della vita reale. Sono attimi che chiedono di fermarsi a pensare per porsi domande in relazione al proprio esserci nel mondo.
Quanto sappiamo su queste tematiche rispetto ai primi filosofi? Difficile pensare ci siano progressi in senso scientifico, ma più prese di coscienza maggiori, una scultura che viene fuori più definita dal blocco di marmo. È proprio snocciolando i concetti tra diversi pensatori che la risposta dovrebbe giungere, quasi comparendo sullo sfondo, ma con il pensiero critico tutto è sempre in bilico e l’autore ci mostra come sia insito nella ricerca stessa il suo essere un asintoto.
Ed è chiaro come venga fuori la figura dell’uomo che si interroga su ciò che vive e pensa, razionalizzandolo come un pellegrino, che sembra la similitudine pertinente per definire quell’essere particolare che è l’essere umano.
Il primo interrogativo affrontato, l’Amore, col capitolo denominato Amor che move il sole e l’altre stelle[1], sottolinea come nell’epoca greca, si usavano parole differenti a seconda della sfumatura di questo sentimento cui ci si voleva riferire. Con il cristianesimo si attua la rivoluzione dell’idea di Amore per Dio e per il prossimo, che diventa il fine ultimo dell’umanità[2].
Il libro approfondisce il tema ripercorrendo la storia della filosofia per arrivare ad una riflessione sull’Amore oggi: gli amanti post moderni oscillano tra due strade reciprocamente opposte e non sintetizzabili in senso hegeliano, perché da una parte la domanda d’amore rimane il desiderio più sentito e agognato, l’esigenza vitale di cercare rapporti che siano stabili e duraturi, ma dall’altra è altrettanto crescente la sottile tendenza a ricercare la novità, il diverso, il brivido, scappando dalla fedeltà e dalla ligia morale di un marito kierkegaardiano che qualsiasi relazione richiede come nutrimento e sussistenza.
Riscoprire l’amare profondo e vedere l’Altro come diverso da noi, un essere unico e non un’estensione di sé stessi come fosse una proprietà, che richiama la visione dell’amore come avere che Fromm affermava.
Poi si passa alla Morte, che in realtà è collegata all’Amore. Vengono ripercorse le riflessioni di numerosi pensatori, dal mondo antico al cristianesimo, dal Medioevo fino all’età moderna e contemporanea. Ad esempio, le parole di Giacomo Leopardi a Fanny Tozzetti: l’Amore e la Morte “sono le sole cose belle che ha il mondo e le sole bellissime degne di essere desiderate”[3]. Molti di loro hanno cercato non solo di dare un senso a quell’evento che — per dirla con Heidegger — segna la fine di tutte le possibilità dell’esistenza ed è l’unico davvero inevitabile, ma anche di indicare vie possibili per accettarlo. Ci ha provato Seneca nelle Lettere a Lucilio, dicendo che la morte è dietro di noi, perché ogni giorno si va verso di essa, e che arrivarci con saggezza è il solo modo per poterla accogliere serenamente[4].
Viene portata alla riflessione la funzione della tomba in una visione materialistica della vita, immagine cardine del pensiero di Ugo Foscolo: per lui è la memoria custodita dalla poesia a garantire all’uomo una forma di immortalità, che vive oltre la morte.
Arrivano dunque Bellezza e Verità, anche qui in un dualismo cercato e voluto, che potrebbe ricordare la bellezza che salva il mondo per Agostino, cioè Dio. Ma questa è solo una delle possibili chiavi di lettura, visto che forse la più famosa è il kalòs kài agathòs di greca memoria. O lo “spaventoso” sublime di Kant, che si ricollega a un bello-vero di Gadamer, cioè l’analogia tra Verità e Bellezza:
come la Bellezza si impone, anche la Verità di un testo, di un’opera si svela come evento, e non è il risultato di una ricerca metodologica che perviene a un risultato certo e oggettivo. L’arte, quindi, è un modo con cui la Verità, che non è mai unica e oggettiva, si rivela nel gioco infinito che avvolge il giocatore-artista[5].
Il registro si presenta con un lessico adatto a tutti, che va dritto al punto, capace di accompagnare il lettore attraverso riflessioni complesse senza mai scadere nel pedante, anche se tende un po’ a generalizzare, facendo storia della filosofia. Ma la conclusione è una sorta di manifesto, di nottola di Minerva che riassume bene la missione della filosofia e la sua immortalità:
Cosa sappiamo dell’Amore? Se non ce lo chiediamo lo sappiamo, se ce lo chiediamo non ne sappiamo niente, rispose Agostino alla domanda sul Tempo. Con la Morte discutiamo, con la speranza di rimandare l’appuntamento fatale […]. Dalla Bellezza siamo attratti e la ricerchiamo in tutte le sue forme, ma non sapremmo spiegare il motivo di una tale, potente fascinazione, dal momento che essa si manifesta in forme così differenti da risultare indefinibile. La Verità ci appare come una meta lontana e irraggiungibile, anche se nessuno vorrebbe trascorrere la propria esistenza nella menzogna e nell’orrore[6].
E in questo anelito che pare una stella polare,
messa tra parentesi l’ossessione per la Verità, la filosofia, che è amore per qualcosa che non si ha, è l’universo letterario dei discorsi che gravitano intorno al Sole opaco della condizione umana[7],
di questa sua privilegiata ma angosciante posizione mediana tra le cose della vita.
Link all'articolo: https://levocidisophia.it/2025/06/26/recensione-3/